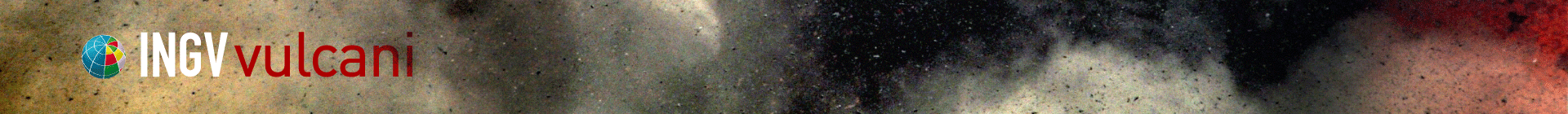Appunti su Vulcano: un racconto di Vitaliano Brancati ci parla degli antichi proprietari dell’isola
di Mario Mattia e Ernesto Oliva *
L’estate, si sa, è il periodo dell’anno durante il quale si legge di più. O almeno così si dice. Per questa ragione, approfittiamo di questa propensione per offrirvi un racconto dai tratti “gotici”. Un’autentica “chicca” trovata tra le pagine di un volume pubblicato nel 1951 dalla casa editrice Flaccovio di Palermo e intitolato “Volto delle Eolie“. Gli autori del volume sono Vitaliano Brancati, Fosco Maraini e Massimo Simili e il racconto che vi proponiamo è proprio dello scrittore catanese Vitaliano Brancati, famoso per i suoi romanzi (e per i film che da questi romanzi sono stati tratti), tra i quali basta citare “Il bell’Antonio”, “Paolo il caldo” e “Don Giovanni in Sicilia”.
I primi anni ’50 dello scorso secolo, per un catanese come Brancati, furono anni strani. La sua città veniva sconvolta da un impetuosa trasformazione, si celebravano i fasti industriali della “Milano del sud”. Interi quartieri venivano abbattuti e grandi viali circondati da banche, assicurazioni e sedi di imprese edili sostituivano il vecchio tessuto urbano, fatto di casupole e strade strette. L’Etna, alla fine del 1950, aveva attirato su di sé l’attenzione di tutto il mondo, minacciando con la sua lava i paesi di Milo e Fornazzo, risparmiati per pochissimi chilometri dalla distruzione. Le isole Eolie diventavano famose per la celebre “guerra dei vulcani”, ovvero la vicenda legata ai due film “Stromboli, terra di Dio e “Vulcano”, girati nelle omonime isole, dove un complicato triangolo amoroso tra il regista Roberto Rossellini e le attrici Ingrid Bergman e Anna Magnani trovava eco in tutti i cinegiornali che celebravano la rivalità sentimentale tra le due donne, tradotta in rivalità cinematografica, e seguita giorno dopo giorno dalla morbosa attenzione del pubblico italiano e internazionale (Figura 1).

Brancati e la sua ironia, invece, si tengono ben lontani dalle beghe scandalistiche e dall’impeto industriale che anima la sua città e, nel racconto che vi proponiamo, rivolge lo sguardo al passato e ci parla dell’isola di Vulcano e dei suoi “proprietari” tra il XIX e il XX secolo. E nelle vicende degli antichi proprietari di Vulcano (allora terra desolata e sfruttata solo per interessi minerari) la penna tagliente di Brancati trova pane per i suoi denti.
Ma adesso ci fermiamo qui e lasciamo che a parlare siano i curiosi protagonisti del racconto “Appunti su Vulcano”.
Buona lettura!
Da cinque giorni in quest’isola vulcanica a mezz’ora di barca da Lipari.
Il mare luccica, chiuso da ogni parte fra rupi nere, ritte, colle corna; dai crepacci, che si aprono mollemente e in silenzio, fuma lo zolfo; una spiaggia è tutta di zolfo, e l’acqua che la bagna va bollendo; nell’interno dell’isola, la terra è arida e nerastra, le canne vi nascono già fradice, il verde delle vigne è sospetto come il colorito dei febbricitanti.
Il corvo svolazza a uncino sulla campagna, e di tanto in tanto precipita come un’ancora che si sia staccata dalla catena.
Quest’isola ha una storia singolare.
I Borboni la regalarono a un signore inglese che non volle mai abitarla.
Mandò in sua vece sua un amministratore, un certo Harley, se ho capito bene il nome, un uomo gelido e decadente che sguinzagliò subito per tutta l’isola dei cani feroci il cui urlo e sgretolare di denti teneva al largo qualunque estraneo.
Si fece costruire un palazzo neoclassico, con portici e colonne, e spianò dei viali lunghissimi, per i quali, ogni pomeriggio, passava tintinnando con la quadriga di cavalli neri (Figura 2).

Era un uomo inospitale, e stabiliva immediatamente, fra sé e gli altri, una corrente di dispetto.
I cani, accarezzati dalla sua mano, lievemente pelosa e sempre con le dita strette, si facevano più feroci, come gatti strofinati contropelo; i barcaioli rispondevano al suo sguardo con la promessa di diventare il meno umani che riuscisse possibile alla loro indole mediterranea; i cavalli, appena egli li sfiorava con la frusta, s’abbassavano sui garretti e volavano con il visibile intento di buttarsi a chiodo nel mare, all’orlo del quale però un urlo secco del padrone li arrestava e immobilizzava come simulacri.
Un pomeriggio, i due figli di Harley, nonostante il divieto del padre, presero una barca e salparono per Lipari.
Il mare era furiosissimo, e l’odore dello zolfo, sbattuto giù dal vento, irritava le gole dei sempre esacerbati abitanti dell’isola, uomini o animali che fossero.
D’un tratto, la barca dei giovani Harley salì al cielo e ripiombò capovolta.
Harley, avvertito dai servi, era già sulla riva, con le braccia conserte e il frustino sotto l’ascella. I pochi marinai presenti, ansiosi di portare aiuto ai naufraghi, tirarono rapidamente e faticosamente un lungo barcone fuori della sabbia e lo spinsero fra gli urti spaventosi del mare.
Ma Harley li fermò con lo sguardo.
‘No’, disse, ‘no!…’
I marinai mogi mogi ritirarono la barca sulla sabbia, si fecero il segno della croce e diedero le spalle al mare, a cui invece Harley continuava a stare rivolto. Di tanto in tanto gettavano una sbirciatina sul viso di lui, cercando di leggervi cos’andasse accadendo ai due sciagurati rimasti in preda alle onde.
Ma il viso del padrone era impassibile, gli occhi vitrei non specchiavano nulla, il naso diritto sembrava, come sempre, vuoto d’aria e di respiro.
D’un tratto, una smorfia di dispetto vi si disegnò come un fulmine.
Harley si volse, salì con un salto sulla quadriga, frustò i cavalli e disparve.
Un minuto dopo, arrivarono stremati, zuppi, seminudi, pallidissimi, i due giovani figli.
La notte, il palazzo rimaneva illuminato: con l’intensità e la costanza di chi si applichi a uno studio, Harley beveva; ogni tanto, veniva sulla terrazza e s’appoggiava alla balaustra, perfettamente immoto, lasciandosi penetrare dal silenzio del mare e del cielo come dal gelo necessario al suo cuore freddissimo.
Un giorno però, mentre egli sedeva solo solo alla sua lunga tavola, i cani emisero un gemito: poco dopo, un crepaccio si aprì nel pavimento e un soffione di zolfo riempì la stanza di puzza e di luce verdastra.
Subito il soffitto s’inclinò, le colonne si contorsero, un fumo intollerabile avvolse ogni cosa.
Il cuore fa dei brutti scherzi. Per sessant’anni, il cuore di Harley era stato coperto di gelo: d’un tratto, esplose in un sentimento di paura.
Tutti gli animali che tremano, senza il soccorso e i freni della ragione, senza che un ricordo, una parola, un’idea venga a salvarli, ebbero in quest’uomo il peggiore esemplare di se stessi.
Harley fuggì a testa bassa verso la riva, si cacciò in una barca, respingendo a colpi di remo i cani che volevano seguirlo e di cui egli aveva ormai un misterioso fastidio come di complici pericolosi, e, remando col fiato tra i denti, sempre a testa bassa, s’allontanò verso Lipari.
Non volle mai più tornare a Vulcano che vendette a tre cittadini di Lipari.
Di questi, due dovettero contrarre gravi debiti per procurarsi la somma richiesta da Harley. Dopo pochi anni, scadenze e interessi li oppressero a tal punto che furono costretti a svendere le loro due parti a un certo signor Fav..
Questi era un siciliano ricco, pigro e pieno di pregiudizi.
Per lui era importante possedere: mettere il proprio nome su una distesa di terra. Le cose disonorevoli erano due: vendere, perché voleva dire trovarsi in cattive acque; e coltivare eccessivamente le proprie terre, perché voleva dire spremerle, avere bisogno, supplicare alberi ed erbe di fargli la carità di una rendita straordinaria.
Con queste leggi, applicate con tanto scrupolo che egli non solo non coltivò eccessivamente le sue terre, ma non le coltivò affatto, il signor Fav. visse e morì.
Oggi le proprietarie di due terzi di Vulcano sono due signorine anziane. I crateri di Vulcano sono due: ciascuna signorina Fav. ne possiede uno, con tutto il territorio circostante.
Non vogliono vendere e non vogliono coltivare. In questa terra arida, basta scavare per una profondità di quattro metri, come ha fatto un animoso italo-americano, il signor Ferlazzo, e l’acqua zampilla.
Tre mesi di lavoro intenso, e quest’isola infernale sorriderebbe.
Ma qui non si coltiva quello che si possiede, né si vende quello che non si vuole coltivare.
Le due padrone abitano a Lipari e le sere d’estate guardano da lontano i loro crateri.
‘E’ il tuo che fuma?’ dice una sorella all’altra.
‘Si, è il mio. Ma mi pare che anche il tuo mandi puzza di zolfo’.
Seggono al balcone di una casa modesta e poggiano la fronte contro la ringhiera di ferro.
Non sognano, non sperano, non temono, non hanno bisogno di nulla.
In un simile stato, il sonno arriva subito: basta reclinare la testa e il cervello, vuoto di pensieri, si riempie di una tenebra densa.
Così s’addormentano. A distanza, dietro le loro palpebre abbassate, i due loro crateri si vanno riempiendo di luce lunare che, mista al verde e al rossigno della pietra, riverbera intorno una luce da oreficeria del diavolo.
* Giornalista RAI – Radiotelevisione Italiana, sede di Palermo